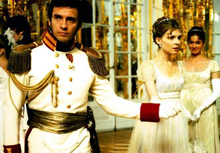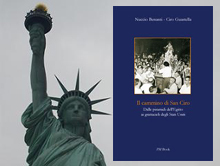di Pippo Oddo
Considerata indiscusso patrimonio dell’umanità, l’immagine marmorea della Madonna di Trapani è un vero capolavoro d’arte finora attribuito allo scultore Nino Pisano, morto nel 1368. La data del suo arrivo nella città da cui ha preso il nome è tuttora ignota per mancanza di precisi documenti storici.
di Pippo Oddo
Considerata indiscusso patrimonio dell’umanità, l’immagine marmorea della Madonna di Trapani è un vero capolavoro d’arte finora attribuito allo scultore Nino Pisano, morto nel 1368. La data del suo arrivo nella città da cui ha preso il nome è tuttora ignota per mancanza di precisi documenti storici.

Sappiamo tuttavia per certo che la gloriosa statua è stata posta subito sotto tutela della Comunità dei “Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo” meglio noti come Carmelitani. I quali, per sfuggire alle persecuzioni islamiche, a partire dal 1226 cominciarono ad abbandonare la Palestina per rifugiarsi in Sicilia e in altre parti del Sacro Romano Impero rifondato da Federico II di Hohenstaufen, lo “Stupor mundi”. A Trapani arrivarono attorno al 1240. «Dove i Carmelitani dimorarono subito dopo il loro arrivo a Trapani – si legge sul web –, non è facile stabilirlo con esattezza. Secondo alcuni storici, essi, per benevola concessione del Senato cittadino, si stanziarono in un primo momento presso la piccola Chiesa di “Santa Maria del parto”, costruita dai pescatori nei primi decenni del XIII secolo vicino l’antica dogana, alle spalle dell’odierna Chiesa dell’ex Collegio dei Gesuiti, accanto alle mura di tramontana della Città. Poi, il 24 agosto del 1250, ricevute in donazione per mezzo di un atto notarile dal notar Domenico Ribaldo e dalla sua prima moglie donna Palma Donores, trapanesi, una piccola cappella, dedicata all’Annunziata e le terre adiacenti ad oriente, fuori le mura cittadine, si trasferirono là per continuare nella quiete della campagna la loro vita comune in ossequio a Gesù Cristo come fraternità contemplativa sulle orme di Maria e di Sant’Elia, il profeta del Carmelo, eremiti non più pellegrini, ora mendicanti itineranti in Europa in mezzo al popolo. Questa data, scrive lo storico Carmelitano Gabriele Monaco (+ 1988) nella sua monografia “La Madonna di Trapani” (Edizioni Laurenziana, Napoli 1981), “sarà segnata a caratteri d’oro negli annali già ricchi di gloria del Santuario”. Al testamento su indicato, ne seguiranno altri: ad opera dello stesso Notar Domenico Ribaldo (8 agosto 1280) e della sua seconda moglie Perna Abate (4 aprile 1289), zii di Sant’Alberto, a motivo dell’ingresso di quest’ultimo nelle terre dell’Annunziata in qualità di religioso. Attraverso questo inaspettato e prodigioso avvenimento in seno alla nobile famiglia, verranno così offerti a favore dei Carmelitani altri possedimenti, per il loro sostentamento e per i lavori di ampliamento della primitiva Chiesetta. Così, per provvidenziale coincidenza, la storia del Carmelo trapanese inizia a legarsi indissolubilmente con la Famiglia degli Abate e, nel corso dei secoli, con altre famiglie nobiliari che, con il benestare e l’ausilio degli stessi sovrani succedutisi nel governo della Sicilia, favoriranno la realizzazione delle pregevoli strutture architettoniche e decorative del Santuario in gran parte giunte fino a noi grazie anche alle cospicue e pubbliche offerte di benefattori di ogni ceto sociale». Quando il futuro Sant’Alberto da Trapani (1240-1307) entrò tra i Carmelitani iniziarono a svilupparsi attorno al piccolo Oratorio dell’Annunziata «il primo vero e proprio Convento di cui, possiamo ben dire, il giovane erede dell’illustre famiglia degli Abate, diventerà il vero fondatore, almeno nel senso che ne favorì il consolidamento patrimoniale del Convento». E non si può escludere che il suo impegno per l’Annunziata «fosse ispirato al disegno di far del suo Ordine Carmelitano pienamente un Ordine Mendicante». Dell’originale cenobio del XIII secolo non rimane quasi nulla, eccetto un arco, una parete e «due piccoli frammenti scultorei, uno in tufo e l’altro in marmo raffiguranti il primo una scena di aratura e il secondo un frammento di architrave, residui, forse, di cultura bizantineggiante». Il santuario che ci è pervenuto è stato realizzato tra il Cinquecento e il Seicento. Non è superfluo aggiungere che «il Convento – che i Carmelitani dovettero abbandonare a motivo della soppressione degli ordini religiosi a causa delle leggi eversive del 1866 –, per la gran parte, è divenuto dal 1905 sede del Museo che più tardi prenderà il nome dal suo ideatore, il Conte Agostino Pepoli; il resto, dal 22 agosto 1930, lo riabita la Comunità dei Frati Carmelitani. Nel Museo, oltre che al Santuario, si conserva in parte anche il “Tesoro della Madonna” con manufatti realizzati tra il XVI e il XIX secolo, testimonianza eloquente della devozione verso la Vergine di Trapani lungo i secoli». Nel frattempo il culto della Bedda Matri di Trapani si era diffuso in diverse parti dell’Isola. Non sono pochi i santuari e le edicole votive a lei consacrati anche nei comuni di altre province. Citiamo il caso della chiesetta del “Miglio” (detta così perché dista circa un miglio da Terrasini). Il 14 agosto essa è meta di un affollato pellegrinaggio di devoti d’ambo i sessi che, perlopiù a piedi scalzi, vi confluiscono cantando: Siti bedda gran signura/, bedda siti ri ‘ncelu e ‘nterra/. Li vostri occhi su du stiddi/, la vuccuzza mi cunzola/. Beddu assai è lu vostru visu/, purtatimi l’arma ‘mparadisu/. (Siete bella gran Signora, bella siete in cielo e in terra. I vostri occhi sono due stelle, la boccuccia mi consola. Bello assai è il vostro viso, portatemi l’anima in Paradiso.) E subito dopo: Quantu tituli c’aviti, / Maria di Trapani patruna siti, / E deci milia voti laudamu a Maria./ E laudata sempri sia, ch’è di Trapani Maria […]. (Quanti titoli che avete, Maria di Trapani patrona siete. E dieci mila volte lodiamo Maria. E lodata sempre sia perché è di Trapani Maria…). Ma è Trapani la città che onora meglio la sua Madonna. Cerchiamo di capire come e perché. Vuole la leggenda che «alla fine del 1100 dei frati carmelitani furono scacciati da Gerusalemme e si recarono, grazie a delle navi, in Sicilia ed alcuni di loro trovarono il loro soggiorno nell'attuale posto adibito al Convento della SS. Annunziata. Contemporaneamente una nave pisana approdò nel medesimo porto depositando una rinomata statua dedicata alla Madonna; dopo aver riparato la loro nave, i pisani non poterono partire se non dopo aver lasciato tale simulacro alla città di Trapani che Le dedicò una splendida cappella. La leggenda ha somiglianze con altre presenti nell'isola e riguardanti altri Santi […], ma quel che conta è la devozione cittadina alla Madonna. Essa è festeggiata con la lavanda dei piedi dei pellegrini che accorrono al santuario e che è svolta dai confrati e dalle consorelle in ricordo della storica lavanda attuata nei secoli passati. Altri elementi delle feste del passato sono andati perduti, ma quel che rimane come costante è certamente la processione della statua della Madonna, attuata dopo la celebrazione dei Vespri e della messa solenne il 15 ed il 16 agosto. La statua della Madonna è portata in processione dai marinai vestiti di bianco». Ma forse il segreto della grande devozione dei trapanesi alla loro Patrona ce lo svela un’altra leggenda raccolta da Bruno Pastena, grande studioso ed estimatore della viticoltura siciliana. Stando al suo racconto, in un’epoca imprecisata alcuni pescatori trapanesi trovarono una cassa in mare. La portarono sulla terra ferma e la posarono casualmente su una vite oramai improduttiva. La aprirono e si accorsero che c’era la Madonna con il Bambino. Il primo a toccarla fu uno storpio, e guarì immediatamente. Nel volger di poco tempo furono miracolati molti altri fedeli che implorarono la Santa Vergine «per la salute del corpo e per maggior fortuna nella vita». Ma si guardarono bene di consegnare la statua alle autorità religiose: la lasciarono lì dove l’avevano poggiato. Nel Trapanese vi fu intanto una grave siccità e i contadini si rivolsero alla miracolosa Madonna per impetrare la pioggia, «una catarratta d’acqua». Non piovve. Ma appena sollevarono la statua per darle degna collocazione dentro una chiesa, notarono che «la vite che aveva fatto da tappeto era diventata una rigogliosa pianta con grappoli turgidi, lucidi, brillanti, e si gridò al miracolo, e per designare la pianta fu coniata la parola Catarratta per l’abbondanza dei suoi grappoli». Allora tutti i viticultori innestarono le loro viti con il Catarratto lucido della Madonna con il Bambino e le vigne divennero «per vendemmie festanti»; ai trapanesi di tutti i ceti, prima tristi e taciturni, affiorò il sorriso sulle labbra. Non si conosce l’epoca precisa dei fatti ma non c’è dubbio – a voler credere alla leggenda – che «fu allora che si notò che la Madonna e il Bambino avevano dipinto nel volto un impareggiabile sorriso, un sorriso al tripudio dei vigneti della provincia più vitata d’Italia». E il Catarratto, si sa, è assieme al Grillo e all’Inzolia un’uva indispensabile per la produzione del Marsala, il vino più famoso d’Europa, quel nettare degli dei tanto caro agli inglesi, alla zarina Alessandra Fedorovna, moglie di Nicola I, zar di tutte le Russie, e persino al governo imperiale austro-ungarico che, con decreto del 16 marzo 1900 lo incluse tra i prodotti della farmacopea austriaca, «da utilizzarsi sia puro sia quale componente degli enoliti»: quel vino “made in Italy” che, in pieno proibizionismo, negli Stati Uniti era regolarmente prescritto dai medici e venduto nelle farmacie, accompagnato dalla denominazione “Florio”. Anche questi sono miracoli ascrivibili alla gloriosa Madonna col Bambino di Trapani. Foto di Caterina Sindoni.













































.gif)