
di Etta Scollo
Arrivaru li navi, tanti navi a Palermu. Li pirati sbarcaru cu li facci di nfernu. N'arrubbaru lu suli, lu suli; arristammu a lu scuru, chi scuru...
















 Lo pensavo conoscendo i particolari legati agli ultimi arresti e apprendendo, nello stesso giorno, che Rita Borsellino chiede al presidente della Regione Raffaele Lombardo un intervento duro contro le fiction sulla mafia girate in Sicilia. Tali ricostruzioni denigrerebbero la Sicilia, veicolando un´immagine falsa che non esiste più. Le questioni sono due. La prima. La politica già influenza abbondantemente quanto passa dalle televisioni. La valutazione va lasciata agli spettatori, che col telecomando decidono cosa vedere. In democrazia, i giudizi di un presidente di Regione, di un capo di governo, dello stesso presidente della Repubblica, devono valere quanto quello di qualsiasi altra persona anonima. E non avere finalità prescrittive di alcun tipo. Non abbiamo bisogno di chi gestisce le nostre serate davanti al piccolo schermo, ma di gente che sappia ben governare. Qualsiasi intervento sui prodotti artistici da parte di chi ricopre un´importante carica istituzionale non potrebbe che rivestire un carattere censorio. Meglio lasciar perdere. Ci vuol poco a debordare. Ironicamente, ma non troppo visto il caso Agrodolce, potremmo ipotizzare una convocazione degli sceneggiatori per capire cosa diamine stanno scrivendo. Con una matita di quelle a doppio colore, si procederebbe a segnare gli errori gravi, da eliminare subito, e quelli meno evidenti, su cui discutere. Chi non ottenesse l´approvazione, dovrebbe mettersi il cuore in pace. Ma non tutti accetterebbero la sentenza. Immaginiamo gommoni, con scafisti d´ordinanza, che nelle notti di mare buono tenterebbero di sbarcare sulle nostre coste protagonisti e comparse, registi e costumisti, cineprese e cavalletti, coppole e lupare. Veniamo al secondo punto. Le fiction veicolerebbero un´immagine deformata della Sicilia, screditandola agli occhi di quanti non vivono nella nostra isola. È un´opinione diffusa. Alla quale si aggiunge la convinzione che negli spettatori si creerebbe una sorta di emulazione per i mafiosi. Disegnati come eroi, quindi facilmente oggetto di imitazioni da parte di giovani e sprovveduti. Che sia chi racconta pezzi di storia recente, o fatti inventati partendo da «libere ricostruzioni» a fare del male alla Sicilia, e non i fatti stessi per come si sono verificati e si susseguono, è davvero un aspetto così controverso che non capiamo come si possa porre. Le operazioni di polizia sui clan mafiosi - sceglietene una a caso tra le ultime - ci mostrano ripetutamente risvolti criminali e politici che neanche le fiction più surreali riescono a riprodurre. Per chiudere il discorso basterebbe solo dire che il mezzo televisivo è cominciato a entrare nelle nostre case nel 1954. Dal 1861, data di nascita convenzionale della mafia siciliana, era già trascorso quasi un secolo. Nel corso del quale di mafia si era parlato a iosa fuori dalla Sicilia. Come avranno fatto gli altri a conoscerla, a farsi varie opinioni su di essa, e sulla Sicilia, molte senz´altro distorte, senza fiction che pompavano falsità? In quanto al discorso dell´emulazione, forse si pensa di avere davanti telespettatori da educare e non individui che guardano e sanno capire con gli strumenti culturali che si ritrovano. Sono cresciuto a Brancaccio. Da ragazzo, durante la seconda guerra di mafia, mentre cominciavano a trasmettere le piovre televisive, accusate di disonorare la Sicilia, vedevo in diretta cos´era la mafia. I morti che lasciava sulle strade. Quelle piovre che uscivano dal piccolo schermo erano acqua fresca. Se proprio avessi voluto imitare i boss, non avrei avuto bisogno di lavorare molto con le fantasie indotte dal mezzo televisivo. Le piovre le ho dimenticate, quel terrore ancora no. Insomma, lasciamo a chi vuole la possibilità di cimentarsi liberamente con le fiction sulla mafia. Quando soggettivamente le troveremo belle, le loderemo, quando personalmente ci parranno brutte, lo segnaleremo. Ricordandoci però, sia nell´uno che nell´altro caso, che sono i fatti, quelli reali, a pesarci sul cuore e sulle coscienze. E a dire agli altri come siamo.
Lo pensavo conoscendo i particolari legati agli ultimi arresti e apprendendo, nello stesso giorno, che Rita Borsellino chiede al presidente della Regione Raffaele Lombardo un intervento duro contro le fiction sulla mafia girate in Sicilia. Tali ricostruzioni denigrerebbero la Sicilia, veicolando un´immagine falsa che non esiste più. Le questioni sono due. La prima. La politica già influenza abbondantemente quanto passa dalle televisioni. La valutazione va lasciata agli spettatori, che col telecomando decidono cosa vedere. In democrazia, i giudizi di un presidente di Regione, di un capo di governo, dello stesso presidente della Repubblica, devono valere quanto quello di qualsiasi altra persona anonima. E non avere finalità prescrittive di alcun tipo. Non abbiamo bisogno di chi gestisce le nostre serate davanti al piccolo schermo, ma di gente che sappia ben governare. Qualsiasi intervento sui prodotti artistici da parte di chi ricopre un´importante carica istituzionale non potrebbe che rivestire un carattere censorio. Meglio lasciar perdere. Ci vuol poco a debordare. Ironicamente, ma non troppo visto il caso Agrodolce, potremmo ipotizzare una convocazione degli sceneggiatori per capire cosa diamine stanno scrivendo. Con una matita di quelle a doppio colore, si procederebbe a segnare gli errori gravi, da eliminare subito, e quelli meno evidenti, su cui discutere. Chi non ottenesse l´approvazione, dovrebbe mettersi il cuore in pace. Ma non tutti accetterebbero la sentenza. Immaginiamo gommoni, con scafisti d´ordinanza, che nelle notti di mare buono tenterebbero di sbarcare sulle nostre coste protagonisti e comparse, registi e costumisti, cineprese e cavalletti, coppole e lupare. Veniamo al secondo punto. Le fiction veicolerebbero un´immagine deformata della Sicilia, screditandola agli occhi di quanti non vivono nella nostra isola. È un´opinione diffusa. Alla quale si aggiunge la convinzione che negli spettatori si creerebbe una sorta di emulazione per i mafiosi. Disegnati come eroi, quindi facilmente oggetto di imitazioni da parte di giovani e sprovveduti. Che sia chi racconta pezzi di storia recente, o fatti inventati partendo da «libere ricostruzioni» a fare del male alla Sicilia, e non i fatti stessi per come si sono verificati e si susseguono, è davvero un aspetto così controverso che non capiamo come si possa porre. Le operazioni di polizia sui clan mafiosi - sceglietene una a caso tra le ultime - ci mostrano ripetutamente risvolti criminali e politici che neanche le fiction più surreali riescono a riprodurre. Per chiudere il discorso basterebbe solo dire che il mezzo televisivo è cominciato a entrare nelle nostre case nel 1954. Dal 1861, data di nascita convenzionale della mafia siciliana, era già trascorso quasi un secolo. Nel corso del quale di mafia si era parlato a iosa fuori dalla Sicilia. Come avranno fatto gli altri a conoscerla, a farsi varie opinioni su di essa, e sulla Sicilia, molte senz´altro distorte, senza fiction che pompavano falsità? In quanto al discorso dell´emulazione, forse si pensa di avere davanti telespettatori da educare e non individui che guardano e sanno capire con gli strumenti culturali che si ritrovano. Sono cresciuto a Brancaccio. Da ragazzo, durante la seconda guerra di mafia, mentre cominciavano a trasmettere le piovre televisive, accusate di disonorare la Sicilia, vedevo in diretta cos´era la mafia. I morti che lasciava sulle strade. Quelle piovre che uscivano dal piccolo schermo erano acqua fresca. Se proprio avessi voluto imitare i boss, non avrei avuto bisogno di lavorare molto con le fantasie indotte dal mezzo televisivo. Le piovre le ho dimenticate, quel terrore ancora no. Insomma, lasciamo a chi vuole la possibilità di cimentarsi liberamente con le fiction sulla mafia. Quando soggettivamente le troveremo belle, le loderemo, quando personalmente ci parranno brutte, lo segnaleremo. Ricordandoci però, sia nell´uno che nell´altro caso, che sono i fatti, quelli reali, a pesarci sul cuore e sulle coscienze. E a dire agli altri come siamo.





 Nella riunione si deciso quanto segue:
Nella riunione si deciso quanto segue: 










 Nella Sicilia arcaica il pane scandiva l’esistenza umana dal primo vagito all’ultimo respiro. Ni porta pani a la casa? Massima che applicata rigorosamente interdiceva ogni miglioramento materiale, sia pubblico che privato, ma serviva a impinguare le rendite delle famiglie. Ora, se portare pane a casa significava per alcuni accumulare avidamente «roba», per moltissimi altri equivaleva a mangiare, attutire i morsi della fame, nulla di più. (leggi)
Nella Sicilia arcaica il pane scandiva l’esistenza umana dal primo vagito all’ultimo respiro. Ni porta pani a la casa? Massima che applicata rigorosamente interdiceva ogni miglioramento materiale, sia pubblico che privato, ma serviva a impinguare le rendite delle famiglie. Ora, se portare pane a casa significava per alcuni accumulare avidamente «roba», per moltissimi altri equivaleva a mangiare, attutire i morsi della fame, nulla di più. (leggi)
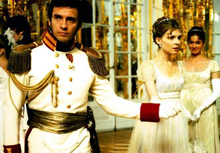 La più grande opera della letteratura narrativa russa del secolo XIX. All’inizio del romanzo, Tolstoj ci fa accomodare nel salotto di Anna Pavlovna Scherer per presentarci uno alla volta i primi personaggi, con pochi ma esaurienti tratti caratteristici. (leggi)
La più grande opera della letteratura narrativa russa del secolo XIX. All’inizio del romanzo, Tolstoj ci fa accomodare nel salotto di Anna Pavlovna Scherer per presentarci uno alla volta i primi personaggi, con pochi ma esaurienti tratti caratteristici. (leggi)
 Di là partimmo per Marineo; la strada è faticosa per le eterne salite e discese. Giuseppe Capuzzi, lombardo, uno dei Mille della prima ora, partito con Garibaldi e Bixio da Quarto alla volta di Marsala, narra nel suo diario (La Spedizione di Garibaldi in Sicilia. Memorie di un volontario) le vicende della spedizione, fino a poco dopo la "presa" di Palermo. Riporto le note del 25 maggio 1860, giornata trascorsa dai garibaldini a Marineo per rifocillarsi. (leggi)
Di là partimmo per Marineo; la strada è faticosa per le eterne salite e discese. Giuseppe Capuzzi, lombardo, uno dei Mille della prima ora, partito con Garibaldi e Bixio da Quarto alla volta di Marsala, narra nel suo diario (La Spedizione di Garibaldi in Sicilia. Memorie di un volontario) le vicende della spedizione, fino a poco dopo la "presa" di Palermo. Riporto le note del 25 maggio 1860, giornata trascorsa dai garibaldini a Marineo per rifocillarsi. (leggi)
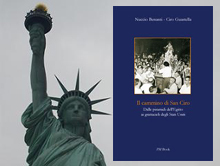 Un'importante tessera al grande e policromo mosaico della produzione saggistica marinese avente per oggetto il santo patrono. Una prima sezione del libro narra della terrena esistenza del medico Ciro e delle vicende che condussero dopo il martirio il suo teschio da Alessandria d'Egitto fino a Marineo. Nella seconda parte si narra come, nelle maleodoranti stive dei bastimenti, San Ciro condusse per mare migliaia di marinesi fino al nuovo mondo, inseguendo sogni di benessere e riscatto sociale. Infine l'ultima diaspora da New York al New Jersey.
(leggi)
Un'importante tessera al grande e policromo mosaico della produzione saggistica marinese avente per oggetto il santo patrono. Una prima sezione del libro narra della terrena esistenza del medico Ciro e delle vicende che condussero dopo il martirio il suo teschio da Alessandria d'Egitto fino a Marineo. Nella seconda parte si narra come, nelle maleodoranti stive dei bastimenti, San Ciro condusse per mare migliaia di marinesi fino al nuovo mondo, inseguendo sogni di benessere e riscatto sociale. Infine l'ultima diaspora da New York al New Jersey.
(leggi)
 Ascoltando la voce di Gesù vendette i suoi buoi e si ritirò in eremitaggio. Fu il superiore dell’eremo di S.Maria della Daina a Marineo. San Benedetto nacque a San Fratello nel 1524 e morì a Palermo il 4 Aprile 1589. Subito dopo la sua morte i francescani lo portano nelle Americhe per convertire gli schiavi africani che la tratta negriera conduceva nelle piantagioni e nelle miniere. (leggi)
Ascoltando la voce di Gesù vendette i suoi buoi e si ritirò in eremitaggio. Fu il superiore dell’eremo di S.Maria della Daina a Marineo. San Benedetto nacque a San Fratello nel 1524 e morì a Palermo il 4 Aprile 1589. Subito dopo la sua morte i francescani lo portano nelle Americhe per convertire gli schiavi africani che la tratta negriera conduceva nelle piantagioni e nelle miniere. (leggi)
 Il proverbio è stato raccolto da Giuseppe Pitrè a fine Ottocento. Rappresenta l’opposizione acqua vs vino, quindi natura vs cultura, volendo rappresentare una località povera di risorse naturali, ma ricca di sapere. O se preferite: ad influenza ellenica. (leggi)
Il proverbio è stato raccolto da Giuseppe Pitrè a fine Ottocento. Rappresenta l’opposizione acqua vs vino, quindi natura vs cultura, volendo rappresentare una località povera di risorse naturali, ma ricca di sapere. O se preferite: ad influenza ellenica. (leggi)