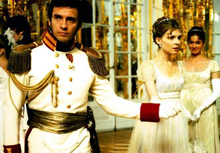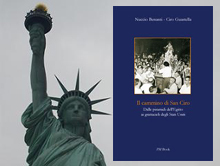di Nuccio Benanti
Nasceva all'ombra della Rocca, in una terra avara alle fatiche umane, e finiva nella pancia del castello dei Beccadelli di Bologna la speranza dei primi braccianti che nella seconda metà del Cinquecento ripopolavano la terra di Marineo.
di Nuccio Benanti
Nasceva all'ombra della Rocca, in una terra avara alle fatiche umane, e finiva nella pancia del castello dei Beccadelli di Bologna la speranza dei primi braccianti che nella seconda metà del Cinquecento ripopolavano la terra di Marineo.

Nasceva nella parte alta del paese, immutata nei suoi tratti secolari, la distesa dei campi di grano: un mare giallo di spighe, interrotto appena da spruzzi di roccia che affioravano sulle onde dei crinali scoscesi. Le pietre squadrate e tirate su dall'uomo convergevano in un fazzoletto urbano che, per volontà e parsimonia dei primi baroni, si stendeva dal castello alla chiesa parrocchiale, per essere destinate alla misura del lavoro umano e della fede cristiana. Intorno al centro abitato era il silenzio dell'uomo e il rumore della natura e degli animali. Pochi gli alberi, pochi i fichidindia e poche le fasce sottili di canneti e vigneti che crescevano discreti ai margini dei viottoli e del seminativo. Nell'anno del maggese, per la terra periodo di riposo, di respiro e di concimazione, i magri fili d'erba alimentavano greggi di pecore e capre affamate e portate al pascolo secondo regole ancestrali di astuzia, cautela e diffidenza. Nell'anno del frumento era un dondolio all'unisono di uomini a dorso di muli e asini, di donne tirate a fatica dalle code degli animali che segnavano, con gli zoccoli consumati dai sassi e dalle zolle, la dura lotta contro il tempo e le avversità della natura, per strappare, fosse anche di notte e con le unghie, i mezzi per una sopravvivenza mai del tutto garantita. Questa era stata la terra di Marineo tra il XVI secolo e gli anni Cinquanta del Novecento: confine naturale del feudo cerealicolo e pastorale corleonese e agrigentino, granaio di Roma e dei Bologna, estremo rifugio della sopravvivenza e della rotazione biennale e triennale, terra cotta dal sole e dalla solitudine, proverbialmente povera di acqua e ricca di vino, ma più nelle secche speranze di salariati e villici che nelle umide botti dei borgesi. I seminativi, un tempo solcati con l'aratro dall'uomo e percorsi a piedi nudi da donne e bambini, oggi vengono calcati da pesanti cingoli e gommati di moderni trattori per seminare nuovi e selezionati germi di vita. E nonostante i drastici cambiamenti economici e sociali che hanno investito negli ultimi decenni il territorio di Marineo, gli antichi usi, costumi e feste contadine continuano a scandire le giornate di un calendario che guarda più al passato che al presente, più al cielo che alla terra, ad avere consistenti e resistenti luoghi di senso accanto a moderne celebrazioni che vedono i devoti portare in offerta sacchi o piatti di frumento per propiziarsi una buona annata. Tra sacro e profano, tra antico e moderno la pratica festiva continua a rispecchiare in modo drammatico e sincero il mistero della vita e della rigenerazione vegetale, del chicco di grano destinato dal principio al sacrificio per produrre molto frutto. Perché da tempo immemore, a Marineo muore e rinasce tra i campi argillosi, e si alimenta come verdi spighe di grano l'attesa, la speranza, l'universale bisogno di costruirsi uno spazio naturale e soprannaturale di sopravvivenza.